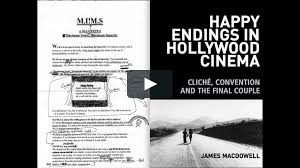Un breve episodio di cronaca parrebbe emblematico a spiegare l’importanza del cinema americano negli anni della Grande Depressione. Il fattaccio accadde nella Carolina del Nord nel 1932, quando un gruppo di disoccupati invase una sala cinematografica pretendendo di vedere il film senza pagare il biglietto d’entrata. L’episodio dimostra come fosse difficile per i cittadini colpiti dalla crisi economica rinunciare a ciò che in quegli anni fu il più diffuso e popolare dei mezzi di comunicazione di massa. Il cinema fu, per molti disoccupati americani dell’epoca, la sola via per impiegare il (molto) tempo libero a disposizione. Le sale cinematografiche, diffuse capillarmente in tutte le città, quartiere per quartiere, erano il luogo più comodo dove poter “ammazzare il tempo”. La gente andava al cinema non soltanto per passare le lunghe e inerziali ore della giornata, ma anche per seguire, si dice (e si diceva), ad occhi spalancati ma pur sognanti, storie fantastiche. Di fatto, diversi osservatori dell’epoca pensarono che il motivo per cui la gente andava al cinema negli anni della Grande Depressione fosse quello di “evadere”, e di sfuggire ad un presente oscuro ed incerto, con una full immersion in storie completamente immaginarie (1).
L’impressione che ebbe la critica contemporanea sembrerebbe confermata dalla più recente “Popular Guide” curata dall’ “Institute for Labor Education and Research” nel 1982, in cui leggiamo:
“The story of some textile workers in North Carolina is typical. In July, 1932, more than 1,000 workers struck to protest wage cuts […] One group marched into a movie theater and demanded admission, ‘declaring that they were out of work and entitled to entertainment.’ When the police broke up their marches and expelled them from the movie theater, the strikers retaliated by shutting down the town’s electricity” (2).
[ La storia di alcuni lavoratori tessili della Carolina del Nord è tipica. Nel luglio del 1932, più di 1.000 lavoratori si mossero per protestare contro i tagli salariali […] Un gruppo marciò su una sala cinematografica e chiese di entrare ‘dicendo che erano senza lavoro e avevano diritto a divertirsi’. Quando la polizia li disperse, cacciandoli dal cinema, gli scioperanti si vendicarono tagliando l’elettricità a tutta la città] .
Ma fosse stato anche vero che i disoccupati cercassero nel cinema soltanto l’evasione dalla realtà e il divertimento, la domanda è: il cinema americano degli anni ’30 “rispose” sempre e comunque alla richiesta del pubblico? La risposta non è così scontata come molti mostrarono di credere e di far credere, perché “qualcuno”, nei primissimi anni ’30, mise in discussione proprio la principale e una delle più rispettate regole della cinematografia popolare intesa come puro divertissement: quella, appunto, del “lieto fine”. Chi fosse stato codesto “qualcuno” è presto detto: trattasi del grande, insuperabile e insuperato Charlie Chaplin.
La “realtà” di Chaplin
Valutando oggi a posteriori, e, qualcuno potrebbe dire, con il senno di poi, un film (comico?) come Luci della città (City Lights) di Charlie Chaplin, ci soffermeremo essenzialmente sul finale. Rinunciando del tutto alla tradizionale conclusione ammiccante a sereni orizzonti, Chaplin si congedava dallo spettatore con una nota amara: la ragazza cieca, la quale era stata aiutata in uno dei momenti più difficili della sua vita dal nostro tramp che s’era spacciato per ricchissimo benefattore, “riconosce” al tatto il suo antico e caritatevole mecenate, il quale, attraverso molte peripezie di stile “comico”, era riuscito a procurarle i molti dollari che le sarebbero serviti per recuperare la vista .
Alla domanda “Ci vede adesso?”, la giovane risponde: “Sì, ci vedo adesso”.
Ma cosa “vede”, in effetti, la ragazza? Vede ciò che “con gli occhi chiusi” (per andare al titolo di un romanzo di Federigo Tozzi) “non” aveva potuto vedere. Non vede più il ricco benefattore che l’aveva tolta dai guai, ma un tramp, che vagabonda per la città, coperto di stracci. La ragazza cioè “vede” la realtà: e l’unica vera realtà di quegli anni era “lo” straccione, che girovagava qua e là sotto le Luci della città.
Si ha la netta impressione che Chaplin, presentando se stesso come il più miserando dei tramp d’America, si fosse rifiutato di offrire agli occhi del pubblico americano la “cieca” visione d’una realtà futura “più bella”; ma, congedandosi dagli spettatori, avesse scelto di aprire i loro occhi solo sull’unica realtà da tutti esperita: quella “stracciona” e senza promesse.
Credo che, da un poeta come Chaplin, non si potesse pretendere l’esibizione di una realtà edulcorata: non al poeta, ma a qualcun altro si sarebbe potuto chiedere qualcosa di diverso.
Forse alla politica?
La “doppia” realtà di Mervyn LeRoy
La Danza delle Luci, del 1933 [Gold Diggers of 1933 di Mervyn LeRoy (con coreografia di Busby Berkeley)], fu uno dei primi film musicali in cui la politica giocò un ruolo fondamentale. Al contrario delle Luci di Chaplin, quelle della “danza” di LeRoy vollero esperire l’uso di “effetti speciali” sul pubblico americano, puntando su un esito che, pirandellianamente, presentasse sì la realtà, ma anche una sorta di suo “doppio”, un’ “uscita di sicurezza”, per riprendere il titolo di un’opera famosa di Ignazio Silone.
La Danza delle Luci non fu così tranchant come City Lights di Chaplin, perché, grazie ai balletti escogitati dalla mente vulcanica di Brusby Berkeley (Buzz), essa diede agli spettatori una visione “duale” della realtà americana. Al balletto d’apertura, guidato da Ginger Rogers che canta “We’re in the money” [siamo in grana] accompagnata da un codazzo di showgirls vestite in costumi ricoperti di monete scintillanti, fa da contraltare l’ultimo balletto, che possiede invece un’evidente connessione con la depressione economica che stava attanagliando l’America.
Il “lieto fine” (3) mostra la corda quando arriva la polizia a confiscare i costumi dei ballerini, costretti perciò ad indossare costumi da mendicanti, levando alti lamenti sull’inganno patito dagli americani, specie dai reduci della prima guerra mondiale. La danza dei cosiddetti “uomini dimenticati” mostra infatti alcuni reduci della grande guerra feriti e delusi, ma che tuttavia marciano con orgoglio: l’intento è di evidenziare come la crisi abbia ridotto gran parte della popolazione alla stregua di miserabili tramp. E qui il film si chiude senza altri commenti e con un triplice matrimonio, ma gli schemi di un “lieto fine” a-problematico, di una storia apparentemente di pura evasione vengono comunque rotti.
Perché dicevamo sopra il film di LeRoy fu un film “politico”?
In effetti, l’operazione intentata dalla Danza delle Luci non fu per nulla “neutrale” rispetto alla politica dell’Amministrazione americana di quegli anni, perché, a quanto pare, dietro le quinte c’era, da parte di alcuni produttori, come i fratelli Warner, una particolare simpatia per il New Deal innescato da F. Delano Roosevelt, che aveva promesso di battersi senza tregua per far uscire il popolo americano dagli effetti disastrosi della crisi economica, facendone intravvedere una possibile soluzione ottimistica. Dietro le quinte de La danza delle luci ci furono dunque i Fratelli Warner, decisamente simpatizzanti del New Deal (4). E ciò in netta controtendenza rispetto alla maggior parte dei produttori di Hollywood, conservatori e fieramente avversi al New Deal stesso. Le “luci della ribalta” giocarono pertanto “effetti ottici” molto particolari: da un lato “abbagliando” lo spettatore, e dall’altro “illuminandolo” realisticamente intorno a possibili scelte politiche, e facendo alla fine propaganda per il New Deal di Roosevelt. Tra l’altro, e per sbirciare ancora “dietro le quinte”, vi fu perfetta sintonia di vedute tra Busby Berkeley e Roosevelt: il primo (Buzz) avendo asserito che, in un’epoca di profonda crisi, egli aveva cercato in tutti i modi di dare una mano agli americani offrendo loro qualche sprazzo di felicità e divertimento (5); il secondo (Roosevelt) sottolineando come fosse bellissimo che gli americani, in periodo di profonda crisi e depressione economica del paese, con la modica spesa di soli 15 centesimi, potessero andare al cinema e farsi quattro risate, dimenticando per un attimo tutti i loro problemi (6)
La terapia del divertimento, inframmezzato però da sprazzi d’una realtà più cruda, fu quindi lo strumento utilizzato negli studi della Warner a supporto della visione ottimistica di Roosevelt, il quale poté contare non soltanto sui fratelli Warner, ma anche su Busby Berkeley, supporter convinto della sua Amministrazione. Danza, coreografia e politica furono gli ingredienti che fecero della Danza delle Luci un prodotto “esemplare” del cinema americano negli anni della Grande Depressione. Come ben scrissero Bruce Babington e P.W. Evans nel 1985,
“Its release thus [coincided] with the height of expectation leading up to the first legislation of the new Congress, and both the anxieties and expectations of this period are refracted in it.” (7).
Note
1) Rodney P. Carlisle, The Great Depression and World War II, New York, Infobase Publishing, 2009, pp. 27-28: “For many unemployed people the cinema was the only way they knew to spend their spare time, and movie-theater chains were spreading throughout the United States during this period”.
2) What’s Wrong with the U.S. Economy?: a Popular Guide for the Rest of Us, South End Press, 1982, p. 304.
3) Il film, che sembrerebbe di pura evasione, inizia con un balletto sontuoso, celebrante la prosperità e il denaro, dove si canta “We’re in the Money” (siamo in grana). Le “grane” però si presentano subito, perché il balletto è interrotto dalla polizia, venuta a pignorare tutto. Ciò rinviava all’ondata di fallimenti innescatisi con la Great Depression, che andava coinvolgendo anche il mondo dello spettacolo, per cui la “fabbrica dei sogni” sembrò incepparsi, rischiando di non funzionare più. Nella New York della Grande Depressione, tre showgirls disoccupate , Trixie, Carol e Polly, condividono un appartamento per via delle ristrettezze economiche in cui versano e perché lo show cui dovevano partecipare era stato annullato per la mancanza di finanziamenti. Le tre ragazze si danno da fare per trovare una via per far quadrare il bilancio, ponendo così le basi per l’evoluzione della trama del film. Le cose sembrano mettersi al meglio quando esse vengono a sapere che il loro produttore, Barney Hopkins, sta per lanciare un nuovo show, in cui potranno di ottenere una parte. Tuttavia egli sembra mancare dei necessari finanziamenti. Nel frattempo, Hopkins sente Brad, un vicino, suonare il pianoforte e cantare, e ne rimane entusiasta. Brad si rivela non solo un abile cantante, ma anche un possibile “generoso” finanziatore del nuovo spettacolo, offrendosi di versare quindicimila dollari. La cosa all’inizio non convince, ma poi si scopre che Brad è il rampollo di una facoltosa famiglia di Boston, con cui Polly si fidanza. Tuttavia, il fratello di Brad, J. Lawrence, e un avvocato di nome Peabody, arrivano all’improvviso, tentando di scoraggiare Brad dallo sposare una semplice showgirl. A questo punto, Trixie e Carol sfoggiano tutto il loro fascino cercando di conquistare i loro sprezzanti avversari (Trixie ci prova con Peabody, mentre Carol con J. Lawrence), che un po’ alla volta cominciano a cedere. Il film termina con una riconciliazione completa, e le tre coppie finiscono per sposarsi. Questo è ciò che si è soliti definire il “lieto fine”.
4) Jeffrey Spivak , Buzz: The Life and Art of Busby Berkeley, The University Press of Kentucky, 2001, p. 72, VII. “It was no secret that the liberal Warner Brothers were enthusiastic supporters of President-elect F. Roosevelt.”
5) Ivi, p. VI: “In an era of breadlines, depression and wars, I tried to help people get away from all the misery. I wanted to make people happy, if only for an hour ”.
6) R. Fehr- F. G. Vogel, Lullabies of Hollywood: Movie Music and the Movie Musical, 1915-1992, Jefferson, North Carolina, McFarland, 1993, p. 141. “During the Depression […] it is a splendid thing that for just 15 cents an American can go to a movie […] and forget his troubles.”
7) Bruce Babington- P.W. Evans, Blue Skies and Silver Linings: Aspects of the Hollywood Musical, Manchester, Manchester University Press, 1985, p. 48. [“La sua distribuzione dunque [coincise] con l’apice dell’ aspettativa che portò alla prima legislazione del nuovo Congresso: le ansie e le aspettative di questo periodo si riverberano perfettamente in esso”]. Per un’analisi sociologica approfondita su Gold Diggers of 1933 e la figura di Busby Berkeley, cfr. l’ottimo articolo di Elisabeth Bronfen, “The Violence of Money”, in Comunicação & Cultura, 2008, n. 6, pp. 53-66, in particolare p. 53: “One of the most frivolous enactments of money Hollywood ever had to offer can be found in Busby Berkeley’s Gold Diggers of 1933. The musical routine a group of showgirls is rehearsing at the beginning of the film is entitled “We’re in the money” and entails a double promise. Clad in costumes adorned with glittering dollar coins, their song and dance routine celebrates the end of the depression by proclaiming that the resurrected silver dollar will once again turn their dreams to gold. With Ginger Rogers leading the other showgirls in their jubilation at regained prosperity, we are offered an erotization of the American dream of creative capitalism. As is usually the case in musicals, this economic encoding of desire, welding money with the beautiful feminine body, is negotiated by virtue of the gaze. The showgirls perform a surplus of money, which gestures towards the pursuit of happiness the constitution declares to be the right of every American. At the same time, albeit more implicitly, an analogy unfolds between the work the showgirls perform on Busby Berkeley’s stage aimed at entertaining the cinema spectators on the one hand, and, on the other, the work performed in the Ford factories, meant to fight the economic depression after the stock market crash in 1929”.